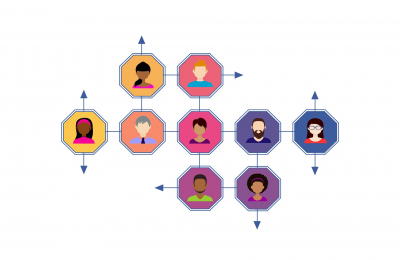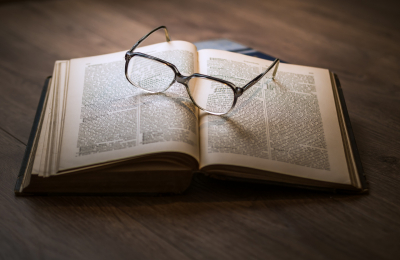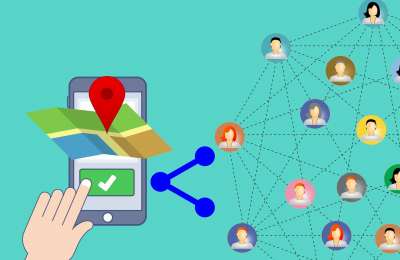“La tecnica non pensa” sembra ammonire Martin Heidegger nel suo saggio "La questione della tecnica" del 1954, eppure l’avvento dell’intelligenza artificiale, proprio perché apparentemente capace di sostituire il pensiero, ci interroga oggi su cosa significhi davvero pensare, decidere, agire con responsabilità.
Il professionista, artigiano della complessità economico-giuridica, si trova oggi di fronte a uno specchio opaco: quello dell’algoritmo che lo imita, lo supporta e – forse – rischia di sostituirlo.
Come possiamo trasformare l’AI in un affidabile alleato ed entro quali limiti?
L’articolo 13 del Ddl 1146/2025: un nuovo confine tra delega e responsabilità
Il Senato italiano ha approvato la scorsa settimana il disegno di legge n. 1146 recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale", un provvedimento che, insieme al Regolamento UE 2024/1689, compone il quadro normativo in tema di intelligenza artificiale applicabile in Italia.
Con 85 voti favorevoli e 42 contrari, il testo ha superato il primo passaggio parlamentare e si appresta ad affrontare l’esame della Camera.
L’articolo 13 del Ddl, in particolare, pone un principio cardine per le professioni intellettuali: l’utilizzo dell’IA è consentito esclusivamente per attività strumentali e di supporto, mentre deve rimanere prevalente il contributo critico e personale del professionista.
La norma, oltre che di natura tecnica, assume il rango di presidio filosofico.
Cos’è la professione intellettuale se non l’esercizio della libertà di giudizio in un contesto vincolato da regole?
Come può l’algoritmo, che non conosce né il dubbio né il rimorso, sostituire un consulente che vive nella carne dei dilemmi normativi e contabili?
Per rispondere a queste domande leggi l'approfondimento di Cesare Tommasetti su Blastonline.it
Ti consigliamo i nostri eBook e Libri di carta:
- Il commercialista e l'Intelligenza artificiale | eBook
- Regulatory Sandbox: analisi e prospettive parlamentari della sperimentazione normativa nel nuovo millennio
- Influencer e intelligenza artificiale | Libro di carta
- Le regole dei dati e dell'intelligenza artificiale
- Intelligenza Artificiale e Risorse Umane
- Il Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale
- Intelligenza Artificiale - Avvocati nell'era di ChatGPT - Libro di Carta
e i nostri Corsi online di formazione:
- Intelligenza Artificiale per principianti | Webinar
- Bilanci e Dichiarazioni con l'AI per Commercialisti
- AI per il controllo di gestione | Corso online
ABBONATI SUBITO a "Luig-IA" la tua consulente virtuale di Studio il primo assistente virtuale che combina l’intelligenza artificiale con una banca dati di oltre 250 eBook professionali, curati e aggiornati da esperti del settore fiscale, tributario e del lavoro.