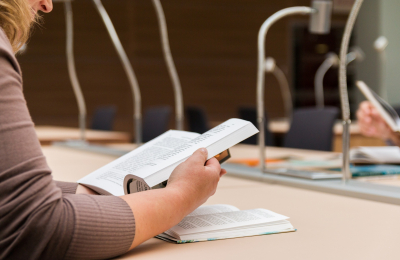La Sostenibilità, variamente declinata, impatta in numerosi settori chiave del diritto, portando con sé «(..) la necessità di ridefinire (e il compito di ri-contestualizzare) le priorità che governano la convivenza civile e i rapporti socio-economici, alla luce delle preminenti esigenze protettive fissate dall’ordinamento giuridico, quali in particolare (..) quelle attinenti alla tutela dei diritti fondamentali e dell’ambiente (..)»[1],
E ciò anche sull’onda delle novelle europee, fra tutte la Direttiva (UE) 2022/2462, ovvero la Corporate Sustainability Reporting Directive (nota anche con l’acronimo «CSRD»), e la sua “gemella”, ovvero la Direttiva (UE) 2024/1760, cioè la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (meglio conosciuta con l’acronimo «CSDDD»): la Sostenibilità, difatti, “travolge” su larga scala le relazioni economico-sociali tutte, quindi sia dal punto di vista dei consumi, che da quello degli investimenti, nonchè delle catene di produzione e di approvvigionamento.
Perciò può affermarsi che è “vasto” il perimetro da applicazione delle due Direttive e che il detto set normativo non può non introdurre quelli che potremmo definire “obblighi diffusi” di Sostenibilità attraverso una “tecnica giuridica”, di cui si parlerà in questo contributo, che rivoluziona le “chiavi di lettura” – fin qui condivise - dei “fenomeni” giuridici.
Ti consigliamo:
- Rendicontazione Volontaria di Sostenibilità | eBook
- Rendicontazione di Sostenibilità PMI – Conforme VSME uno strumento pratico e guidato per PMI che vogliono essere al passo con i nuovi standard ESG.
- Sostenibilità e Appalti - Requisiti chiave per la partecipazione alle gare | Libro
- Rendicontazione sostenibilità e Modello di Business PMI | eBook
- La revisione del reporting di sostenibilità ESG | Libro
- Reporting di sostenibilità ESG | Libro
- Direttiva Sostenibilità aziendale: profili giuridici | eBook
Vuoi sapere quando è sostenibile la tua azienda da 0 a 100? Scopri l'algoritmo di sostenibilità progettato ad hoc per le normative europee ed italiane con il Software Ecomate
1) Il contratto, l'autonomia contrattuale e la Sostenibilità
Le novelle politiche europee di Sostenibilità, unitamente al conseguente set normativo, impongono una integrazione dei c.d. Fattori ESG nei rapporti fra privati e così facendo coinvolgono il diritto contrattuale ed i principi che lo governano.
Su questa scia il contratto, così come lo abbiamo conosciuto, “tramonta” definitivamente, per trasformarsi in «(..) una categoria giuridica che si integra nella dimensione sociale, sicchè il contratto si qualifica esso stesso come prodotto o fenomeno sociale (..)»[2].
Il contratto, cioè, abbandona la staticità per diventare un “fenomeno” dinamico, che acquisisce una dimensione “storica”: il contratto diviene “sensibile” all’evoluzione “del/nel tempo”, “attraversando” ideologie e momenti storici, economici e sociali.
La storia, ma soprattutto la storia del diritto ci mostra come i mutamenti socio-economici abbiamo via via impattato sulla stessa “definizione” del contratto ed ora, nell’epoca della Sostenibilità e della Globalizzazione, siamo testimoni della diffusione di modelli contrattuali atipici come pure di prassi internazionali, che hanno spinto e spingono per una ulteriore ed innovativa “rilettura” del contratto.
Ed è proprio il Paradigma della Sostenibilità che ha contribuito maggiormente al “ripensamento” di tale figura giuridica, secondo nuove prospettive, grazie anche alla recentissima riforma di matrice euro-unitaria al riguardo: come noto il Legislatore europeo si è mosso (e si muove) nell’ottica di una forte integrazione dei Fattori ESG nei rapporti fra privati, facendo sì che il “nuovo contratto” porti con sé risvolti “disciplinari” di singolare rilevanza.
«(..) L’emersione di istanze egalitarie e di sostenibilità e le risposte rimediali offerte a livello eurounitario conducono, quindi e senz’altro, ad ulteriori sviluppi (..) definendo in nuovi termini i confini delle libertà private e apportando correttivi, sempre più penetranti, a meccanismi di mercato reputati inadeguati a fornire spontaneamente risposte efficaci o omogene a problemi complessi, che esulano dalla ristrettezza dei confini nazionali (..)»[3].
Sostanzialmente cambia la stessa “essenza” del contratto, non più individualista, antropocentrica ed incentrata essenzialmente su una dimensione esclusivamente patrimoniale dei rapporti inter partes.
Il contratto, cioè, nell’era della Sostenibilità, diviene l’espressione di una “visione personal-collettivistica dell’esperienza giuridica”[4], per cui al suo interno trov,a financo, spazi sempre più ampi la tutela di interessi terzi, estranei alla singola dinamica contrattuale. In tal maniera viene ridimensionato pure il limite della relatività degli effetti del contratto sancito dall’art. 1372 c.c.[5]
Il motivo di una tale “rivoluzione” risiede nella indubitabile saldatura fra la Sostenibilità ed il principio di solidarietà economico-sociale di cui all’art. 2 Cost., che coinvolge non solo la parte pubblica, ma anche il privato, rafforzata, in Italia, dalla recente riforma costituzionale, a mezzo della L. Cost. 11 febbraio 2022 n. 1, coerentemente declinata sulla scorta delle regole euro-unitarie.
L’autonomia privata, quindi, si trova a dover “convivere” con nuove limitazioni, ulteriori rispetto a quelle fin qui note, funzionali al sistema concorrenziale di mercato: le nuove limitazioni hanno origine dalla Sostenibilità e quindi dal “principio dello Sviluppo Sostenibile”: entrambi operano in una dimensione «(..) sovra settoriale e a livello trasversale (..)»[6], nonchè intersoggettiva, avendo effetto su miriadi di rapporti.
Ti consigliamo:
- Rendicontazione Volontaria di Sostenibilità | eBook
- Rendicontazione di Sostenibilità PMI – Conforme VSME uno strumento pratico e guidato per PMI che vogliono essere al passo con i nuovi standard ESG.
- Sostenibilità e Appalti - Requisiti chiave per la partecipazione alle gare | Libro
- Rendicontazione sostenibilità e Modello di Business PMI | eBook
- La revisione del reporting di sostenibilità ESG | Libro
- Reporting di sostenibilità ESG | Libro
- Direttiva Sostenibilità aziendale: profili giuridici | eBook
Vuoi sapere quando è sostenibile la tua azienda da 0 a 100? Scopri l'algoritmo di sostenibilità progettato ad hoc per le normative europee ed italiane con il Software Ecomate
2) Il contratto, la Sostenibilità e la value chain
Pertanto, il diritto contrattuale, all’epoca della Sostenibilità, non può non adottare un metodo di tipo funzionale: detto diritto cioè diviene strumento di governo dell’economia, grazie a regole di condotta che operano come incentivi o disincentivi.
In quest’ottica, lo scambio non è solo circolazione e produzione di ricchezza, ma è anche soddisfacimento di un bisogno, sia esso materiale o spirituale, che si parametra con le categorie della Sostenibilità, nelle sue molteplici declinazioni ecologiche, sociali, di inclusività, di responsabilità della Governance ecc, innovando i parametri di valutazione, dalla prevalenza del “valore d’uso” all’odierno “valore di scambio”.
In un siffatto contesto appare evidentemente desueto il modello economico affidato alle sole logiche di massimizzazione del profitto, senza tenere conto delle altre importanti variabili e/o necessità del mercato reale “raggruppate” in quel concetto di Sostenibilità che fonda le scelte, poi, del consumatore.
Le transazioni economiche e l’operare privato sono, infatti, influenzati dalla tavola dei valori della Sostenibilità, al di là degli obblighi normativi che pur sussistono: solo un prodotto che ha valore per l’acquirente e soddisfa un suo fabbisogno acquisisce un fattore di unicità in grado di assegnare all’impresa un vantaggio competitivo in termini di differenziazione[7].
Tale consapevolezza ha condizionato e condiziona le scelte strategiche delle imprese, soprattutto delle multinazionali [8], le quali si orientano per un modello di business e produttivo rispettoso dei diritti umani e degli ambienti naturali e sociali in cui “vivono”, proprio per incrementare la reputation sul mercato e per ispirare fiducia (di lungo periodo) negli investitori e consumatori.
Ed è in questo humus che ha maggiormente attecchito il c.d. “contratto moderno” che può essere rappresentato come un «(…) “contratto poliedrico”, quale strumento di auto-regolamentazione o regolamentazione, utilizzato, nell’era della globalizzazione, dalle imprese (..) per regolare il loro “modello” produttivo-distributivo (..)» lungo tutta la filiera, nel quale vengono integrate le istanze di Sostenibilità: in questo quadro il contratto, quindi, acquisisce una funzione di governance che trascende financo gli stessi contraenti.
Il “fenomeno” può essere sintetizzato nell’espressione «(..) il contratto al posto della legge (..)»[9] e l’odierno assetto normativo complessivo, grazie soprattutto alle citate Direttive, è evidentemente orientato al c.d. private lawmaking, terminologia con la quale si «(..) designa un effetto normativo, elevando a regola di condotta della comunità politica (e dell’ente che ne è esponenziale) la disciplina adottata dai portatori di interessi particolari al fine di regolare i propri rapporti giuridici patrimoniali quali “siano il …nome, il procedimento di formazione, e l’organo da cui …promana” tale effetto normativo (..)»[10].
Ovvero, il private lawmaker è, e rimane, un soggetto privato, ma le sue regole hanno un effetto normativo, che si estende ben oltre la c.d. self-regulation, divenendo dette regole la «principale fonte di regolazione del diritto dei contratti commerciali e finanziari. Nel diritto statale, il suo rilievo è assicurato dalle norme dispositive (default rules) (..)»[11]
Di più, le regole del private lawmaker operano secondo un “sistema a cascata” che determina “un effetto contagio a catena” diffuso, o anche “effetto valanga”, lungo tutta la filiera produttivo-distributiva “principale” ed sua volta sulle filiere produttivo-distributive di ciascuna impresa facente parte della supply chain principale.
Da qui l’obbligo diffuso di Sostenibilità.
3) Il private lawmaking e l'obbligo diffuso di Sostenibilità
La predetta “tecnica” del private lawmaking, ed il suo “sistema a cascata”, sono alla base delle menzionate Direttive (e del complessivo nonchè stratificato set normativo di riferimento) e del D. Lgs. 125/2024 (che recepisce la CSRD): il Legislatore li utilizza per “diffondere” l’obbligo di Sostenibilità, così da accordare tutela ad interessi generali o per soddisfare particolari diritti sociali.
Quindi, può affermarsi, senza tema di smentita, che la soluzione offerta dal novello Legislatore, per assicurare livelli e modalità di produzione che si facciano carico delle esternalità negative, a tutela dei diritti fondamentali e dell’ambiente, nonchè una condotta aziendale responsabile orientata alla dovuta diligenza, muove sì dai postulati propri dell’autonomia privata, ma fa sì che il contratto assurga a strumento di governance delle relazioni economiche che regolano i molteplici processi del ciclo produttivo[12], potendosi parlare all’uopo di contract governance in assonanza e/o in analogia con la corporate governance.
D’altra parte, le richiamate norme richiedono alle big companies (quali “obbligate dirette”) di predisporre e/o di implementare al meglio un sistema di gestione organizzativa nonchè di monitoraggio dei processi interni (affinchè siano coerenti con il principio della dovuta diligenza) e dei rischi, che ricomprenda «garanzie contrattuali circa l’osservanza dei principi e standard di sostenibilità (….) da parte dei partners commerciali, i quali, a loro volta, sono tenuti ad adoperarsi per ottenere analoghe garanzie dalle loro controparti contrattuali nella value chain», per es. attraverso codici di condotta, codici etici, politiche di sostenibilità, clausole ad hoc all’interno degli stessi contratti ecc.
Alla luce di ciò, perciò, può affermarsi che è indubitabilmente immanente, vista la CSRD ed il suo recepimento attraverso il D. Lgs. 125/2024, un obbligo diffuso di Sostenibilità, che porta con sé nuove ed aggiuntive “forme di inadempimento” contrattuale e responsabilità civile, poiché nel perimetro dell’autonomia privata sembrerebbero rientrare financo doveri generici di neminem laedere al di là dell’area dell’illecito civile.
Di più, gli obblighi di due diligence, contenuti nella CSRD, e quindi nel D. Lgs. 125/2024 che la recepisce nonchè nella CSDDD, «(..) sottendono un dovere di do no significant harm, che funge da limito implicito al libero dispiegarsi dell’iniziativa privata e quale norma protettiva a beneficio dei diritti o interessi tutelati nelle convenzioni e negli strumenti internazionali (..)»[13] di settore, facendo financo balenare la configurabilità financo di un diritto di credito in capo a soggetto terzo.
4) Conclusioni
In conclusione, è possibile affermare che il novello Legislatore:
- ha riconosciuto al contratto il ruolo di «(..) congegno del e nel mercato, funzionale a contrastare fenomeni lesivi di interessi qualificati di assoluta rilevanza per l’ordinamento (..)»[14] per l’effetto
- ha definito in maniera più stringente i limiti dell’autonomia contrattuale, sulla convinzione della irriducibilità dei diritti fondamentali (rispetto alle necessità contingenti e/o di breve periodo) quale cifra delle tutele di long termism[15] e conseguentemente
- ha reso indubitabilmente immanente l’obbligo diffuso di Sostenibilità.
Ne consegue che tutte le imprese, nessuna esclusa (se si vuole restare ed essere competitivi sul mercato), sono chiamate ad iniziare ed a percorrere la “strada” verso la Sostenibilità, nella consapevolezza che per “diventare Sostenibili” non basta “un click”.
[1] così Degl’Innocenti F., Verso un’autonomia contrattuale sostenibile, p. 9, 2024, Pisa
[2] così Degl’Innocenti F., op. cit., p. 14
[3] così Degl’Innocenti F., op. cit., p. 19
[4] in tal senso Nervi A, Beni comuni, ambiente e funzione del contratto, in Pennasilico M. (a cura di), Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale, Napoli, 2016, p. 55
[5] in tal senso Perlingeri P., Persona, ambiente e sviluppo, in Pennasilico M. (a cura di), Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale, Napoli, 2016, p. 324 s.s.; Roppo V, Il Contratto, Milano, 2011, p. 544; Mengoni L, Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano, 1996, p. 63
[6] così Degl’Innocenti F., op. cit., p. 55
[7] in tal senso v. Porter M, Il vantaggio competitivo, Torino, 2004, p. 151 s.s.
[8] Sul punto si ricorda quanto affermato dalla Prof.ssa Pistor, la quale, nel suo libro The Code of Capital – The Law Creates Wealth and Inequality, riferendosi alle multinazionali, utilizza la locuzione holders of global capital, per individuare appunto quei soggetti economici transnazionali i quali cercano di “determinare” contenuti, decisioni e convergenze fra ordinamenti nazionali, con la finalità di remunerare i propri interessi economico-finanziari nonchè il capitale investito dai propri azionisti, nella loro qualità di detentori di leve finanziarie ed economiche globali per mezzo delle loro supply chain mondiali. Sul punto v. Roi M., ESG e le catene del valore: la Corporate Sustainability Due Diligence Directive, Santarcangelo di Romagna (RM), 2024, p. 84 s.s.
[9] così Rolli R, Contract Governance e sostenibilità, in DB Non Solo Diritto Bancario, v. www.dirittobancario.it, 31 luglio 2024, p. 7
[10] così Nicolini N., I processi di decisione politico-normativa come private lawmaking, Sezione monografica: Diritto e pandemia tra rotture e continuità, 1/2023, p. 61, in DPCE On Line, v. https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1817
[11] così Nicolini M, op. cit., p. 64
[12] sul punto v. Roi M., ESG e le catene del valore: la Corporate Sustainability Due Diligence Directive, Santarcangelo di Romagna (RM), 2024, p. 81 s.s.; Grundmann S, Cafaggi F e Vettori G, The Organizational Contract. From Exchange to Long-Term Network Corporation in European Contract Law, Abingdon, 2013
[13] così Degl’Innocenti F., op. cit., p. 135
[14] così Degl’Innocenti F., op. cit., p. 166
[15] sul punto v. Rodotà S., Il diritto di avere diritti, Bari, 2012